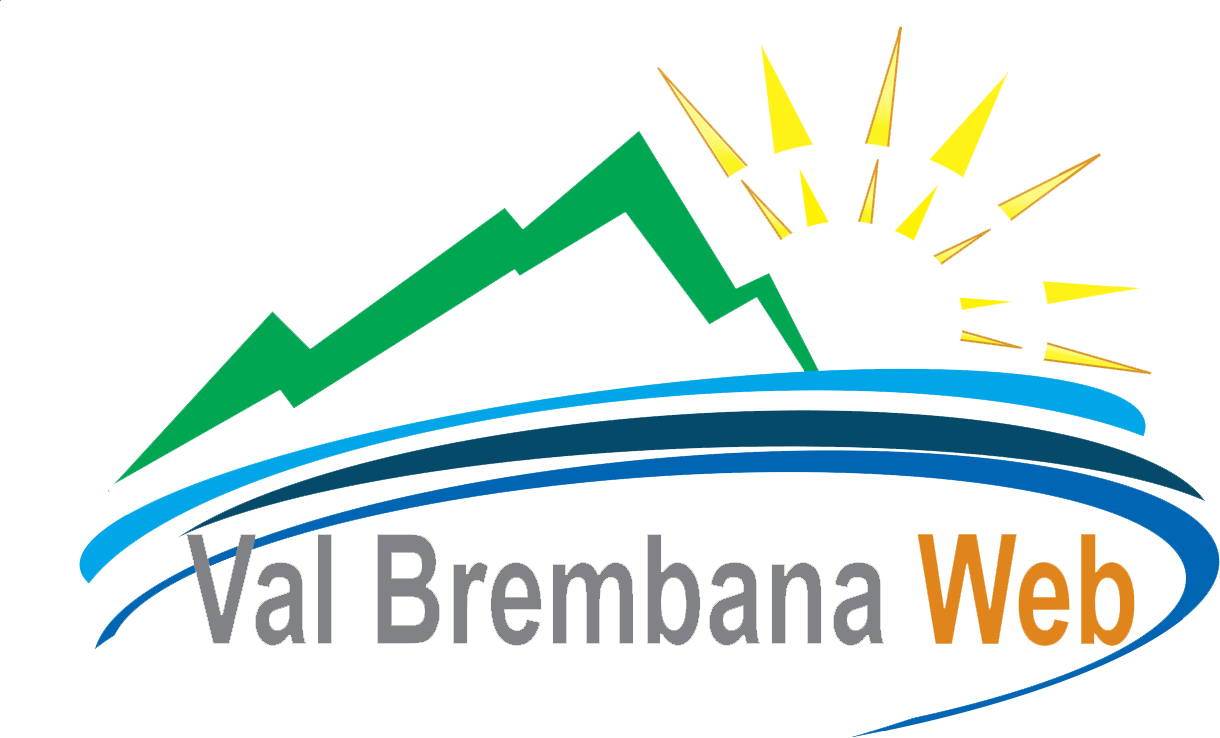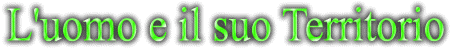
-
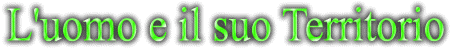
 |
L'opera dell'uomo si e' esplicata in un continuo lavoro che riscontriamo nelle manifestazioni esterne, borghi antichi, rurali, opere di architettura rustica, artigianato costituiscono l'espressione della cultura e della civilta' di un popolo. Le genti della montagna Brembana, abitanti in posizione geografica lontana |
 |
Un Gruppo di donne Brembane all'epoca in posa durante una pausa di lavoro |
 |
Nel gia' citato Museo della Valle di Zogno si possono ammirare arnesi di lavoro ed oggetti di vita quotidiana ormai scomparsi dall'uso comune ma una volta erano parte viva della durissima vita agricola, che si svolgeva nella Valle Brembana. La vita che si svolgeva nelle valli era una vita comunque dura, di lavoro dall'alba al tramonto, soggetta ai ritmi della natura con periodici periodi di carestia . A cavallo dell'inizio del secolo e sino ai giorni nostri le valli Brembane hanno alimentato emigrazione. Gli antenati dei Milanesi "Brembilla o Brambilla" erano sicuramente originari della Val Brembilla. Bergamaschi emigrarono in Francia, come Taglialegna, in Belgio ed in Val d'Aosta come Minatori, in Svizzera come operai durante lo scavo dei Trafoi ferroviari e stadali. Dovunque hanno raccolto manifestazioni di stima per la loro tradizionale operosita'. |
Val
Brembana . . . una Valle di Emigranti
-
Di
questa storia di emigranti fanno parte nomi destinati a diventare famosi
come quelli di Palma il Vecchio, del Codussi, dei Baschenis, dei Santacroce
o delle compagnie dei Caravana e dei Bastagi. Ma accanto ad essi ecco poi
migliaia di anonimi facchini, carbonai, boscaioli, minatori, fabbri, muratori
e servette. Era del resto (ed e' ancora purtroppo) quello dell'emigrazione
un fenomeno fisiologico in tutte le vallate alpine come la nostra, povere
di risorse.
| Ogni fazzoletto di terra, ogni anfratto veniva lavorato e sfruttato con incredibile tenacia, in modo da poterne ricavare quel tanto che bastava per i bisogni essenziali. Ma era inevitabile che periodicamente il rapporto tra popolazione e risorse si squlibrasse oltre ogni limite sopportabile ed ecco allora la valvola di sfogo dell'emigrazione, e cioe' il trasferimento in altri luoghi lontani dove potersi guadagnare quanto serviva per integrare gli scarsi redditi della nostra miseria economia, rendendo possibile la sopravvivenza delle famiglie e della comunità. Se qui stava la motivazione principale, non e' poi affatto da escludere che avesse in molti giovani un peso anche la voglia di evadere dal nostro piccolo mondo, di conoscere altri cieli, genti e culture, di realizzarsi in modo piu' completo. Cosi' come ebbe certamente la sua parte anche un certo spirito di imitazione. Tesi queste avvalorate dal fatto che non tutti gli emigranti erano in stato di ingigenza o di necessità. Non pochi di essi appartenevano infatti a famiglie benestanti e comunque in grado di garantire loro una pacifica esistenza. |
 |
Era
dunque la nostra fino al Novecento e oltre, a parte quella trasoceanica,
un'emigrazione quasi sempre di tipo temporaneo o stagionale. Generalmente
si partiva tra Febbraio e Aprile e si tornava tra Ottobre e Dicembre, all'arrivo
della brutta stagione, quando il freddo e la neve impedivano di lavorare
nei boschi, dov'era impegnata la grande maggioranza dei nostri emigranti.
Una mamoria della depurazione provinciale di Bergamo inviata al Ministro
dei lavori pubblici l' 8 Marzo 1900 in merito alla questione delle derivazioni
delle acque del Fiume Brembo riporta i seguenti dati:
-
| Piazza
Brembana: Popolazione: 14.336 - Emigranti: 3.040
Zogno: Popolazione: 30.859 - Emigranti: 4.338 Totale Valle Brembana: Popolazione: 44.859 - Emigranti: 7.358 |
Testo tratto dal Libro "Il Novecento" di Felice Riceputi